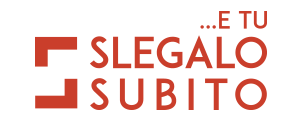05 Lug #Basaglia180X40: Sulla necessità di una nuova 180
Il lavoro culturale, 2 luglio 2018
Pubblichiamo un estratto da “Basaglia e le metamorfosi della psichiatria” l’ultimo libro dello psichiatra Piero Cipriano, edito da Elèuthera (2018).
Questo contributo rientra nel progetto di approfondimento #Basaglia180X40 realizzato in occasione dei 40 anni della Legge180 e che proseguirà fino alla metà di giugno attraverso la pubblicazione di estratti, riflessioni e segnalazioni.
È gennaio 2018, un paio di mesi fa due senatori, Nerina Dirindin e Luigi Manconi, hanno presentato un disegno di legge dal titolo: Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180. Possiamo chiamarla, per semplicità, 180 bis. Se dietro la 180 c’era Basaglia, dietro la 180 bis c’è la mano di Franco Rotelli e Peppe Dell’Acqua, che ne hanno preso l’eredità. Insomma, quaranta anni dopo, c’è questa necessità di ribadire una legge che – a quanto pare – non è stata attuata, oppure non è stata applicata. Soprattutto, questa 180 bis, sottolinea e enfatizza alcuni aspetti che la legge 180, in quanto legge quadro, non aveva indicato. Ad esempio formalizza meglio il TSO, introducendo un quinto attore, un garante, che renda ancora più indaginosa la sua esecuzione e ne impedisca l’uso arbitrario e poliziesco. Ad esempio esplicita che i reparti ospedalieri detti SPDC dove trovano ricovero le persone con crisi psichica acuta e dove si effettuano all’occorrenza i TSO non siano dei bunker chiusi e non vi si adoperi la contenzione meccanica, non si leghino le persone con le fasce, insomma. Ad esempio stabilisce che i servizi di salute mentale debbano ricevere almeno il 5% della riserva finanziaria destinata alla salute. Cosa che in Italia è prevista ma quasi nessuna regione ottiene.
Ecco allora che mentre scrivo questa breve storia, e tutto sommato la scrivo più che altro per me, per chiarirmi le idee, mi domando il senso di questa legge-che-ribadisce. Legge che, scrive Ivan Cavicchi, si limita tutto sommato a difendere il “nucleo teoretico della 180”, nel senso che con questa repetita non sembra esserci alcuna evoluzione, ma “si continua a pestare la solita acqua nel solito mortaio”. E, aggiunge, “alle generazioni post-basagliane questa situazione va molto stretta”.
Secondo Cavicchi la non applicazione della 180 è dipesa prevalentemente da un inadeguato finanziamento dei dipartimenti di salute mentale. Vale a dire: c’è un aumento del malessere psichico, tale che si configura quasi un’epidemia (basti considerare, come detto prima, la depressione, che si appresta a diventare la prima causa di morbilità, e tra qualche anno sopravanzerà i disturbi cardiovascolari), e perché mai lo stato “abbassa le difese” smantellando servizi, svuotando CSM, riducendo operatori? Lo stesso stato, sostiene Cavicchi con un paragone stringente, che obbliga a fare decine di vaccini a fronte di epidemie inesistenti, rispetto all’oggettiva epidemia di male psichico, perché non fornisce l’unico vaccino possibile, ovvero capillari dipartimenti di salute mentale? Un autentico paradosso, sembrerebbe.
Allora, per un verso questo discorso, pensateci, fila. Potenziare i DSM, intesi non come manuali diagnostici nordamericani ma come Dipartimenti di Salute Menatele. E’ bizzarro che due dispositivi a mio parere antitetici abbiano lo stesso acronimo. Aveva ragione George Orwell a diffidare degli acronimi. Dico: potenziare i servizi territoriali. Ma come, per fare cosa? Per curare chi? Per curare come? Quali interventi? Aumentare i farmaci? Le psicoterapie?
Prendo in prestito ancora per un po’ le suggestioni di Cavicchi: chi è il paziente che il nuovo DSM, il Dipartimento di Salute Mentale potenziato dalla 180 bis, intende tutelare?
Nel 1978, chiusi i manicomi, il soggetto da tutelare era l’internato dimesso dal manicomio, dunque, per tornare ancora una volta alla dicotomia kraepeliniana che tanto ha condizionato la psichiatria e gli psichiatri: era lo psicotico, o meglio lo psicotico istituzionalizzato.
In questi quarant’anni gli psicotici non sono – per magia – guariti, ci sono ancora, altroché, con o senza manicomio, ma il nuovo soggetto, emergente, da prendere in cura è un soggetto un po’ meno paziente dello psicotico e un po’ più esigente – per dirla con Cavicchi. Probabilmente è il soggetto che alimenta la nuova epidemia di ansia e depressione – di cui ho scritto prima – o anche di disturbo bipolare o anche di quei cosiddetti disturbi della personalità che si è soliti definire borderline. Sono loro, i soggetti incasellati dentro queste etichette che, fomentati da questa società performativa descritta da Han, richiedono cosmetici psichici più che antipsicotici, non tranquillanti ma energizzanti. Non farmaci per spegnere ma farmaci per accendere. O al massimo per stabilizzare le proprie oscillazioni umorali.
Dunque, forse, è cambiato il tipo di pazienti di cui un centro di salute mentale si deve occupare.
A settembre 2017 ero con Peppe Dell’Acqua e Pier Aldo Rovatti a Mantova, festival letteratura, parlavamo di pillole di diverso colore per ogni specifico dolore, questo il titolo accattivante del nostro spazio. Io ho fatto un intervento centrato su questa nuova epidemia determinata dal pernicioso connubio tra diagnosi by DSM-5 e psico-cosmetici. Raccontavo in che modo si è prodotta questa epidemia di depressione e disturbo bipolare. Raccontavo di questo nuovo manicomio non appariscente, che è diagnosi e farmaco dipendente. Peppe a un certo punto è intervenuto, per dire attenzione, vi sono persone chiuse nel loro autismo, nel loro delirio, nelle proprie voci, che hanno bisogno di essere rassicurate circa la necessità di queste terapie, farmacologiche e non solo, è a loro che serve un centro della salute mentale. Ecco. Secondo me avevamo ragione entrambi. Però era come se avessimo in mente due tipi diversi di soggetti da tutelare, separati pure noi da questa dicotomia kraepelinia, lui vedeva gli psicotici, sia gli ex internati sia i nuovi che non hanno conosciuto il manicomio, io vedevo gli affettivi o gli ansiosi o i bipolari o quelli dalla personalità drammatica, resi molto più sofferenti di quel che potrebbero essere da queste nuove diagnosi di manica larga e da questi nuovi farmaci dati allegramente per tutta la vita.
Avevamo, abbiamo, ragione entrambi. Allora qual è il dipartimento di salute mentale che, al meglio, deve ottimizzare le poche risorse economiche a disposizione? Vale ancora la dicotomia di cui parla Rotelli, efficace senz’altro negli anni Ottanta Novanta di fuoriuscita dal manicomio, tra servizio forte e servizio debole? Qual è oggi un servizio territoriale forte?
E’ fuori luogo pensare che (e mica è un paradosso) un servizio forte sia un servizio che riesca a farsi promotore della salute mentale della popolazione che ha in carico, aggredendo con decisione e competenza la iatrogenia che sempre l’intervento medico porta con sé? Ovvero manifestando un’attenzione estrema al come far diagnosi, al non etichettare più del dovuto persone che hanno una sofferenza che un tempo si sarebbe detta normale – lutti, tristezze, timidezze – e di conseguenza non innescare dipendenze farmacologiche senza ritorno responsabili di escalation farmacologiche e posologiche? Essendo – gli psichiatri – non solo prescrittori ma economisti, voglio dire che abbiano sempre in testa quanto costa ogni farmaco che prescrivono. E se è possibile ottenere lo stesso effetto anti-delirio o anti-allucinazioni con un farmaco di cinque euro invece di un farmaco iper-pubblicizzato di seicento euro, semplicemente: optino per il primo.
Ciò determinerebbe un risparmio che moltiplicato per cento, per mille, per diecimila pazienti, un dipartimento di salute mentale può investire in altro. Ovvero nei cosiddetti interventi complessi che riguardano l’abitare, il lavoro, la formazione, le relazioni delle persone.
Ieri ero in SPDC, vado in pronto soccorso con due tirocinanti, uno specializzando in psichiatria che ha già fiutato in che imbroglio si sta cacciando e una psicologa, più ingenua, per ora, che pensa che tutto si risolva in psicoterapia. Mi chiamano per un marocchino di trentasette anni, falegname, che mai ha avuto prima disturbi psichici. Ora, da tre settimane, ha l’ansia. E’ nervoso. Perché? E’ successo qualcosa? Dice uno non mi ha pagato duemila euro per il lavoro che gli ho fatto. E ci credo che sei incazzato. Questa si chiama essere incazzato, non è ansia non è depressione, anche se andando a compulsare i nove criteri per la depressione sono sicuro che cinque te li trovo e di certo hai superato il limite delle due settimane per cui avresti tutte le carte in regola per entrare nel girone dei depressi, saresti ecco il quattrocentomilionesimo e uno, ma io non voglio convincerti che sei depresso, e non voglio darti un antidepressivo e nemmeno un’ansiolitica benzodiazepina, guarda un po’, perché non voglio essere iatrogeno, non voglio essere complice di questo fenomeno di medicalizzazione e psichiatrizzazione dell’umanità, che poi arriva l’epidemiologo e mi viene a dire che c’è un’epidemia, e non sa magari che quell’epidemia sono stato io a contribuire a crearla, perché l’epidemiologo compulsa numeri non storie, noi esseri umani siamo storie, siamo biografie non numeri.
Allora la mia azione oggi è duplice. Uno ho creato un depresso di meno, oggi c’è un non depresso in più sul pineta Terra. Dico senti, trovati un avvocato e fatti pagare. A un certo punto ti passerà. Se ti do un farmaco stai sicuro che per altri vent’anni questo farmaco nessuno te lo toglie, e sei fottuto. Due ho insegnato a questi due tecnici della salute mentale in formazione che il buon tecnico della salute mentale non è il diagnosta che conosce a pappagallo i criteri americani e sa fare due e tre diagnosi insieme e gli sa dare un farmaco o due. Il buon tecnico è colui che ha capito il trucco, e non fa danni, non genera iatrogenia. All’università mi insegnavano, nella clinica più farmacologica d’Italia, come si aggancia un paziente. Proprio così dicevano: agganciare. Esattamente ciò che Basaglia, nei suoi mesi negli USA intuì. Prendere nella rete. Il paziente ha dei sintomi, ogni sintomo si giova di uno o più farmaci. Se non gli dai il farmaco te lo perdi. Se gli dai il farmaco lo agganci. Ora: perché questo imperativo di agganciarlo? Per essergli utile? Certo che no. Erano i consigli delle case farmaceutiche. Perché i pazienti sono consumatori di farmaci, e ogni paziente agganciato sono una due tre molecole che lui ingoierà per il resto della sua vita.
Fatta la consulenza, dopo aver convinto il falegname incazzato che non necessitava di farmaci, mentre torniamo nel SPDC la tirocinante psicologa mi fa: d’accordo no farmaci, ma almeno un po’ di psicoterapia gliela potevi consigliare. E perché? Per aiutargli a gestire la rabbia, fa lei. Capisco che siate tanti, poveri psicologi, e dobbiate convincere il mondo che il vostro non sia un mestiere inutile, ma… perdonami, quell’uomo non aveva bisogno di psicoterapia. Fa lei: ma è gratis. Io non dico da un privato. Dico al CSM. Se va a un CSM è gratis. No, le dico. Non lo è. E’ gratis per lui ma lo stato ti paga a te psicoterapeuta del CSM pubblico che stai sprecando mezz’ora per fare la psicoterapia a un falegname incazzato perché non è stato pagato. E ti paga per un lavoro inutile. E’ uno spreco di risorse. Non è convinta, maledizione. A quel punto gli racconto dello psicanalista Massimo Recalcati, che sostiene di saper trattare persone con disturbi gravi e perfino i poco abbienti, perfino i migranti. Qualche anno fa, le dico, mentre percorriamo il chilometrico corridoio che ci porta dal pronto soccorso al padiglione A e infine nel reparto psichiatrico, fu intervistato nel suo confessionale, dove, così era scritto, tutto è come ti aspetti in questi casi, silenzio, lettino, luci basse, tinta pastello dei muri, invece, stai entrando nello studio di un rivoluzionario della prassi medica, di un carbonaro della psiche, di un eretico della élite terapeutica più snob che esista.
E qual era l’eresia di questo psicanalista?, fa lo specializzando che, fortunato lui, ancora non lo conosce.
Pensare che la psicanalisi possa essere una cura alla portata di tutti. Era così convincente, che quando l’ho letta un altro po’ correvo a farmi psicanalizzare pure io.
Dice la tirocinante psicologa: alla portata di tutti, in che senso?
Ma uscendo dalle torri d’avorio!, proclamava l’analista eretico. E il chiavistello, per questa rivoluzione copernicana, era nelle tariffe. Quelle del mercato vanno da 100 a 150 euro tre quattro volte a settimana. Il nostro psicanalista giustamente le considera immorali. Dice che così si fa una selezione naturale del paziente. E qual era la sua proposta? Quale la parcella onesta? Be’ lui aveva deciso di infrangere il tabù dei sacri testi – secondo cui sarebbe la tariffa alta che incentiva il paziente alla guarigione, capito che geni? – e fare i conti con l’ostracismo della categoria, e fondare una onlus senza fini di lucro. E offrire terapie a basso prezzo. Il cui fine era riassunto in uno slogan perfino anarchico: a ciascuno secondo i propri bisogni, da ognuno secondo le proprie possibilità. Sedute al massimo di quaranta euro e studi che nascono in periferie. Solo in questo modo, sostiene, riesci a intercettare finanche il bisogno di cura dei migranti, e delle persone con problemi di droga, e con disturbi alimentari, eccetera.
A parte che ci sarebbero i centri di salute mentale, che sono gratis in quanto servizi pubblici, fa Matteo, lo specializzando.
Infatti. Ma comunque. Facciamo due conti, con soli quaranta euro, mettiamo che veda il migrante una sola seduta a settimana. Quaranta per quattro fanno centosessanta al mese. Bisogna informarlo, allo psicanalista eretico, che ancora lo aspetta il suo primo migrante. Questo falegname marocchino non lo vedrai mai, neppure col binocolo.
E poi, fa lo specializzando: psicoterapia sì, ma quale psicoterapia? Ci saranno duemila scuole, nel mondo, io ne dovrei scegliere una e non c’ho proprio idea.
Io pure, gli dico, a trent’anni ero indeciso tra il perdermi nei meandri del mondo junghiano, o darmi all’epistemologia sistemica, ben deciso a scansare come la peste il freudianesimo il lacanesimo e tutto ciò che ci girava attorno, mai su un lettino mi dissi, nemmeno legato, e alla fine mi diedi al cognitivismo. Ma senza nessun entusiasmo, capiamoci. Infatti non mi definisco certo un cognitivista.
La futura psicoterapeuta: ma perché ce l’hai con Freud?
Io: ma perché è stato il primo a dichiarare terapia la pratica, millenaria, di ascoltare e parlare. In realtà ha inventato una forma di retorica. E’ retorica l’arte di scrivere o parlare in pubblico per persuadere. Roba da politici. Cosa fa la coppia terapeuta paziente? Parlare e ascoltare a senso unico, il paziente parla di sé e il terapeuta parla del paziente. La psicoterapia è retorica, nient’altro che retorica, o meglio, Eschilo parlava di iatroi logoi (parole curative), allora meglio chiamarla iatrologia. Allora, giovani iatrologi che non siete altro, ci fermiamo a prendere un caffè alle macchinette?
Va be’, fa la giovane psicologa, ma che vuol dire, che tu non fai lo psicoterapeuta?
Ma sì. Ma non voglio far credere che parlare e ascoltare, ovvero comunicare, sia una tecnica di cura. Vedi, ormai andare in barca è terapia, ascoltare musica è terapia, andare a cavallo è terapia, correre è terapia, ogni attività umana è stata resa terapeutica. Ebbene Freud aveva cominciato prima, scoprendo l’acqua calda, cioè che parlare con un’altra persona fa bene. Poi è successo che tutti i suoi epigoni si sono inventati un metodo, ognuno l’ha reso peculiare, chi pensa che il fulcro sia l’Edipo, chi si basa sui sistemi d’attaccamento eccetera. E sono nate le duemila scuole che dici tu, Matteo.
E tu che fai, quando fai psicoterapia… o meglio, quando parli con le persone per farle star meglio?
Provo a mettere insieme questa iatrologia, per dirla con Eschilo, con la letteratura. Il romanzo, secondo Milan Kundera, conosce l’inconscio da prima di Freud, la lotta di classe da prima di Marx, la fenomenologia da prima di Jaspers. James Hillman ha scritto un libro molto bello, Le storie che curano, ve lo consiglio, in cui assimila la psicoterapia a una narrativa che cura. Come se ciò che definiamo sé fosse un sé narratore, che per tutta la vita non fa altro che raccontarsi, raccontare, il sé insomma è un narratore. Noi tutta la vita non facciamo che raccontare e raccontarci. A ognuno peraltro ci raccontiamo in modo diverso. Abbiamo tanti sé quanti interlocutori abbiamo, e dunque quanti racconti di noi facciamo.
E dunque? Chiedono all’unisono. Com’è che da questo si può far terapia?
Ma semplice. Trasformando i casi clinici, ovvero le anamnesi asettiche e fredde dove tutto è centrato su sintomi eventi di vita traumi lutti in racconto. Però, e qui è il trucco che rende il racconto terapeutico, il racconto deve diventare un racconto nuovo, dove la persona paziente si racconti in un modo diverso, più accettabile, rispetto a quanto non ha fatto fino a quel momento.
Insomma, questo faccio, ragazzi, ascolto storie, costruisco storie, restituisco storie, sono uno storico un biografo un narratore un basagliano, Basaglia fuggiva a gambe levate dalle teorie e faceva lo storico, sia della psichiatria sia delle persone.
Insomma, questo faccio, con i tirocinanti. Controinformazione. Mettere il dubbio nella loro formazione universitaria a senso unico. In alcuni il dubbio apre delle crepe, altri li vedi, sono già impostati in un certo modo, col marchio di fabbrica, inattaccabili, non c’è più niente da fare.
Oggi un amico friulano mi invia una ricetta erogata da una psichiatra di un CSM della sua città. Vi sono prescritti circa dieci farmaci diversi. Il paziente ha quasi settant’anni, lo conosco, ha un passato di elettroscioccamento, alle presentazioni dei miei libri, quando le faccio dalle sue parti, mi viene sempre a trovare e chiude le presentazioni con una barzelletta su Cristo. Esilarante. Non la racconto qui anche se sono tentato. Da scompisciarsi. Recentemente, è stato ricoverato in SPDC dove nottetempo è stato legato. Nottetempo non c’è lo psichiatra, avrà deciso l’infermiere. E’ stato ricoverato in SPDC perché il CSM 24 ore, in realtà, è aperto solo di giorno per mancanza di operatori. Altrimenti, vi fossero gli operatori, sarebbe stato aperto anche di notte e lui avrebbe trovato ospitalità lì, e forse non sarebbe stato legato in SPDC. Mancano le risorse, insomma. Ma se riducessimo il carico di farmaci a questo pazientissimo paziente e agli altri mettiamo mille di quel CSM, e se fossimo più attenti al designare le persone pazienti e iniziarle ai farmaci, quanto risparmio potremmo avere, quanti operatori in più per tenere aperto il CSM giorno e notte, di modo che il mio amico che racconta le barzellette e i pazienti più gravi non vengano legati quando sono in crisi?