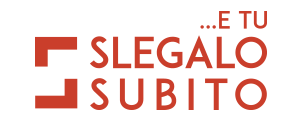29 Apr Da Marco Cavallo a oggi: i 40 anni della legge Basaglia
Il Corriere della Sera, 29 aprile 2018
di Elena Tebano
Marco Cavallo uscì dal manicomio una bella domenica di marzo. Azzurro come il cielo di primavera, arrivò fino a Piazza Unità, il cuore di Trieste, accompagnato da almeno 600 «matti». Era il 1973, Marco Cavallo, la pelle di cartapesta e nella pancia i sogni degli internati, era una scultura: doveva il suo nome a un altro cavallo, lui sì in carne ed ossa, che i pazienti dell’ospedale psichiatrico di Trieste l’anno prima avevano salvato dal macello. Alto tre metri, gli aveva fatto strada Franco Basaglia, psichiatra e direttore della struttura, che con una panchina di ghisa aveva sfondato il cancello di legno che ne bloccava l’uscita.
 Diventò il simbolo di quei «matti» decisi a non morire chiusi in manicomio. Fino ad allora ci finiva chiunque venisse ritenuto «pericoloso a sé e a gli altri e di pubblico scandalo» come sanciva la legge del 1904. «Fu una grande macchina teatrale per comunicare il cambiamento culturale portato avanti da Basaglia ed altri medici che denunciavano la violenza e l’esclusione dell’internamento», dice oggi Franco Rotelli, psichiatra e presidente della Commissione Sanità del Friuli Venezia Giulia, che quel giorno era lì e nel 1980 succedette a Basaglia alla direzione dei servizi di salute mentale triestini.
Diventò il simbolo di quei «matti» decisi a non morire chiusi in manicomio. Fino ad allora ci finiva chiunque venisse ritenuto «pericoloso a sé e a gli altri e di pubblico scandalo» come sanciva la legge del 1904. «Fu una grande macchina teatrale per comunicare il cambiamento culturale portato avanti da Basaglia ed altri medici che denunciavano la violenza e l’esclusione dell’internamento», dice oggi Franco Rotelli, psichiatra e presidente della Commissione Sanità del Friuli Venezia Giulia, che quel giorno era lì e nel 1980 succedette a Basaglia alla direzione dei servizi di salute mentale triestini.
Una rivoluzione culturale sfociata il 13 maggio 1978 nella legge 180, che aboliva l’istituzione manicomiale e restituiva dignità e pieni diritti civili ai malati psichiatrici. Ma che oggi, a 40 anni dalla sua approvazione, ancora non può dirsi compiuta: «Siamo a metà del guado. Una volta fatta — spiega Rotelli — la legge 180 è stata subito dimenticata». Non solo perché disponeva che non si potesse più entrare negli ospedali psichiatrici ma non quando uscissero i malati che erano già dentro (alcuni ci sono rimasti fino all’inizio degli anni 2000), ma perché andava costruita l’alternativa. «I servizi per la cura fuori dagli ospedali psichiatrici hanno tardato a nascere e per anni– avverte Rotelli – la loro qualità in giro per l’Italia è stata molto bassa, anche se ci sono luoghi, tra cui Trieste, in cui si è riusciti a costruirne di buoni. Va bene perché i manicomi erano una realtà pesante e nel resto d’Europa ce ne sono ancora tanti. Ma molto rimane da fare».
Intanto sono sempre di più le persone di cui farsi carico: l’Organizzazione mondiale della sanità stima che una persona su 4 nel corso della vita attraversi un problema di salute mentale. «E negli ultimi anni la domanda è cresciuta per impatto della crisi economica che ha aumentato il malessere psicologico» afferma il presidente della Società italiana di epidemiologia psichiatrica Fabrizio Starace. Nel 2015, l’anno a cui si riferisce il primo e finora unico Rapporto sulla salute mentale in Italia (Rsm) del Ministero della salute, sono state 777.035 le persone seguite dai servizi di salute mentale. «Varie indagini condotte nel corso degli anni, però, indicano che in Italia ci sono circa 2 milioni di individui che presentano disturbi psichiatrici. A cui vanno aggiunti – prosegue Starace – gli individui a rischio di disturbi ansiosi e/o depressivi: altri 4 milioni e mezzo secondo un’indagine Istat del 2013».
Le risorse disponibili non bastano per assisterli: la rete dei servizi, costituita da Centri di Salute Mentale, centri diurni e strutture residenziali, conta 3.791 strutture in cui lavorano 29.260 dipendenti (57,7 ogni 100 mila abitanti). Un dato medio, che nasconde differenze enormi: si va dal minimo di 20,6 operatori ogni 100 mila abitanti in Molise al massimo di 109,3 in Valle D’Aosta, mentre lo standard individuato dal Progetto Obiettivo del 1999 prevederebbe come minimo 66,6 operatori ogni 100 mila abitanti. «C’è una grave carenza anche di fondi: la Conferenza delle Regioni nel 2001 – aggiunge Starace – aveva stabilito che venisse destinato alla salute mentale il 5% della spesa sanitaria: solo Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna ci arrivano, mentre la media è del 3,5%. L’Italia è oggi il Paese occidentale avanzato che meno investe in questo settore». «La conseguenza – spiega Gisella Trincas, presidente nazionale dell’Unasam (l’Unione nazionale delle associazioni salute mentale, che rappresentano i malati e i loro familiari) – è che la maggior parte dei malati non ha uno psicologo e viene curata solo con i farmaci».
E in assenza di personale adeguato succede che sia ancora diffusa una pratica ereditata dai manicomi, la «contenzione meccanica»: legare i pazienti. «Ricerche recenti – dice Giovanna Del Giudice, portavoce del Forum Salute Mentale – hanno dimostrato che nei reparti degli ospedali destinati al ricovero temporaneo dei pazienti in crisi acuta si contiene nell’80 % dei casi. E questo nonostante la Commissione parlamentare per i diritti umani abbia accertato che legare viola la costituzione oltre che la dignità dei pazienti». Almeno due persone sono morte in Italia in anni recenti dopo essere state legate a un letto d’ospedale per giorni: Giuseppe Casu a Cagliari nel 2006 e Francesco Mastrogiovanni a Vallo della Lucania nel 2009. Eppure le alternative ci sarebbero. «La persona però – sottolinea Giselle Trincas –deve essere presa in carico nella sua interezza, da un’equipe di professionisti che collabori a un progetto personalizzato di cura, che includa anche la famiglia e la rete affettiva dei pazienti. Servono psichiatri, psicologi, operatori ed educatori che insieme costruiscano una relazione di fiducia col malato. Così guarire è possibile, ci sono persone che sono riuscite a uscire dalle diagnosi più feroci».
Quando le cose funzionano, i malati al Centro di salute mentale trovano lo psichiatra per la terapia farmacologica, gli psicologi per la psicoterapia, soluzioni abitative alternative se hanno problemi a vivere con la famiglia, l’accompagnamento dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, laboratori con gli educatori, visite domiciliari degli operatori sociosanitari. E anche i ricoveri nelle fasi acute della malattia vengono decisi con il loro consenso. È un percorso lungo che comprende l’inserimento lavorativo e che spesso, quando le risorse pubbliche non ce la fanno, viene portato avanti dal volontariato: «Noi cerchiamo di costruire – dice Beatrice Bergamasco, presidente di Progetto Itaca, la più grande onlus italiana specializzata su questo tipo di assistenza – una rete di relazioni intorno alle persone di cui ci occupiamo: facciamo formazione con i familiari, organizziamo i fine settimana e attività diurne nel nostro centro e abbiamo anche una «job station», un centro in cui le persone lavorano con il telelavoro per diverse aziende con cui collaboriamo».
Sono ancora pochi oggi invece i centri del servizio sanitario che riescono a seguire i malati fino in fondo nel reinserimento sociale. Ma le esperienze che funzionano, come quelle in Friuli Venezia Giulia eredi di Basaglia, o a Modena, in Emilia Romagna, dove centinaia di persone sono coinvolte in percorsi di inclusione sociale lavorativa, dimostrano che è possibile. Certo, servono risorse adeguate e una cultura che «non riduca la malattia mentale alla medicalizzazione – sintetizza Franco Rotelli – L’ultimo manicomio che ancora rimane in piedi è quello farmacologico». Solo quando la salute mentale saprà curare tutti gli aspetti della vita dei malati potrà dirsi davvero compiuta la riforma di 40 anni fa.