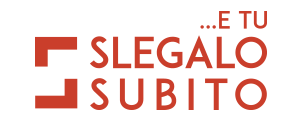11 Apr La crocefissione di Maria. Storia di una foto

Repubblica.it, 11 aprile 2017
di Michele Smargiassi
Primo ritaglio.
Un lettino di ferro con le sbarre bianche e un corpo nudo, quello di una bambina tra i sette e i dieci anni. Che è una femmina, si capisce solo dal taglio tra le gambe unite e tenute ferme da una cinghia di contenzione. Anche le braccia sono legate alle sponde con due strisce di tela e tutto il peso del corpo si regge sui gomiti. Dietro la schiena, un cuscino macchiato e sotto il sedere, una tela cerata. Nell’angolo in fondo a destra si intravede un materasso a righe. Poi c’è il buio.
Secondo ritaglio.
E allora, anche il capo reclinato della bambina, coi suoi capelli quasi rasati, diventava un pezzo di quella drammatica composizione che si completava con i piedi uniti e le caviglie strette da altre cinghie. Quale fosse la composizione era chiaro: una crocefissione. La testa piegata verso il petto, come il Cristo in croce; le braccia larghe, i piedi uniti. Al posto del legno, il ferro del letto, ammorbidito appena da un materasso, ma se il Cristo avesse avuto diritto a quel residuo di pietà che, con lo straccio, gli aveva coperto i lombi, la bambina era stata rappresentata nella sua più indifesa nudità.
Sono due descrizioni di una immagine attraverso parole. Sono due ekphrasis, direbbero i greci antichi. Sono due descrizioni della stessa fotografia. Apparse su due libri diversi, quasi contemporaneamente, quasi cinquant’anni dopo che quella fotografia vide la luce.
Il primo ritaglio viene da La prima verità, di Simona Vinci, uscito nel 2016. Il secondo da Quello che l’acqua nasconde di Alessandro Perissinotto, uscito pochi mesi dopo. Nessuno dei due scrittori sembra aver saputo nulla del testo dell’altro. Nessuno dei due scrittori cita nel brano chi scattò quelle fotografie. Vinci ammette anche di non aver saputo nulla, a lungo, delle circostanze, del luogo, del contesto di quella foto.
Credo che Mauro Vallinotto, il fotografo che la scattò, reporter militante e oggi attento analista di immagini, non sia affatto irritato da questa sua eclisse di autore. È la prova che quell’immagine è diventata patrimonio della coscienza civile di un paese intero. Lo ricorderà da domani una mostra, al Castello di Rivalta, Torino.
È la prova che quella sua fotografia fu chiamata dalla storia a fare il suo lavoro. È la dimostrazione che esistono immagini necessarie, a cui un fotografo consapevolmente consente di esistere. Fu pubblicata sul paginone centrale de L’Espresso, nel numero del 26 luglio 1970. Sotto il titolo dolorosamente sarcastico “Ma è per il suo bene!” Il caso Villa Azzurra era scoppiato da alcuni mesi, parte di un crescente allarme per le condizioni dei ricoverati negli ospedali psichiatrici di Torino.
Vallinotto riuscì a entrare nel reparto B di quell’istituto, collegato al più noto Ospedale Psichiatrico di Collegno. Di quel giorno, oggi conserva
un ricordo che il tempo ha molto stemperato: era l’inizio di luglio, faceva molto caldo (ecco anche un motivo del perché la bambina, a differenza degli altri suoi compagni, fosse tenuta nuda sulla cerata del letto). Ero entrato nella palazzina grazie ad un’assistente sociale che sapeva della sorveglianza allentata durante il cambio turno. Il tutto durò una manciata di minuti, 52 scatti in totale su due rullini di Tri-X. Il ricordo più persistente è curiosamente quello delle mosche che a frotte si posavano indisturbate sui volti dei bambini.
 Nell’articolo che accompagnava il servizio fotografico il giornalista Gabriele Invernizzi, che però non era presente, racconta che la piccola sorrise ai visitatori sconosciuti, cercò di alzarsi a sedere sul letto e di tendere loro una mano ma non ci riuscì, perché le cinghie la tenevano stretta.
Nell’articolo che accompagnava il servizio fotografico il giornalista Gabriele Invernizzi, che però non era presente, racconta che la piccola sorrise ai visitatori sconosciuti, cercò di alzarsi a sedere sul letto e di tendere loro una mano ma non ci riuscì, perché le cinghie la tenevano stretta.
Non vediamo sorrisi nella fotografia, e Mauro su questo è trasparente:
La bambina non sorrise e non cercò di alzarsi, rimase semplicemente a guardarmi, muta come molti dei suoi compagni.
Quel che successe dopo la pubblicazione di questa fotografia è raccontato in Portami su quello che canta, il libro-inchiesta che Alberto Papuzzi dedicò allo scandalo e al processo a carico del direttore Giorgio Coda, detto “l’elettricista” a causa della sua predilezione per l’elettroshock.
Oggi quella fotografia è il cardine di una mostra che celebra i quarant’anni della legge Basaglia che abolì i manicomi.
La storia di quella battaglia è trapunta di immagini. Si può anzi dire che le immagini furono la scelta delle armi di quella battaglia, a cominciare da quell’album viola edito da Einaudi, Morire di classe, pamphlet durissimo che Franco e Franca Basaglia stessi chiesero ai fotografi Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin di aiutarli a costruire. Era uscito l’anno prima, nel 1969. Per la storia e il carattere di questa alleanza fra pensiero antipsichiatrico e fotografia, lunga, intensa e a volte non priva di ombre, vi rimando se credete a un altro articolo di Fotocrazia.
Lasciatemi tornare a questa specifica fotografia, alla sua efferata potenza. Posso dirlo? Al modo in cui ci ossessiona, ancora oggi. Ben descritto da Simona Vinci, che ha la stessa età di quella foto:
Sono anni che questa foto mi insegue. L’ho stampata su un foglio A4 e l’ho appesa con due pezzi di scotch strappati con i denti. L’ho appesa al muro, alla parete di un armadio, a uno specchio, a una porta, l’ho appesa in ogni stanza nella quale mi sono ritrovata a lavorare in questi ultimi anni. E l’ho fatto prima di sapere in quale angolo del mondo fosse stata scattata, in che anni, e quale fosse la sua storia.
Nel servizio dell’Espresso (dove le fotografie apparvero non firmate, per proteggerne l’autore da denunce) c’erano altre foto drammatiche di torture chiamate “mezzi correttivi”. Nell’enorme album della fotografia antimanicomiale ci sono molte altre immagini di disperazione, violenza, dolore.
La fotografia della bambina nuda ha qualcosa di più. Una “geometria del dolore” che Perissinotto legge per noi così:
Il sesso nudo della bambina occupava l’asse verticale dell’immagine. Era lì che si posava il primo sguardo, con l’imbarazzo di chi avverte il sordido spettro della pedofilia insinuarsi incontrollato. Ma da lì risaliva rapido, in cerca di qualcosa di meno insano; risaliva lungo il corpicino, nudo anch’esso, e all’altezza delle spalle, abbandonava l’asse centrale per spostarsi prima a sinistra e poi a destra. In quel punto una linea orizzontale intersecava perpendicolarmente la mediana dell’immagine; era la linea delle braccia, innaturalmente aperte. Gli occhi le seguivano fino a scoprire, sui polsi, le due cinghie che le fissavano alle sponde del letto e che le bloccavano in quella posizione anomala.
La nudità, segno di in ocenza indifesa e offesa, e le braccia in croce. Viene in mente, inevitabilmente, prepotentemente, un’altra immagine. Quasi coetanea. Avete già capito quale: la bambina del napalm, la piccola vietnamita Kim Phuc dalla schiena bruciata, fotografata da Nick Ut. Anche lei è nuda (e questo, per le regole di pudore della stampa americana, stava per impedire a quella fotografia di apparire sui giornali: se non si fosse impuntato il direttore della Ap in Vietnam, Horst Faas, che minacciò le dimissioni se non fosse stata diramata dall’agenzia). Anche lei ha le braccia in croce.
Una fotografia scattata dall’altro capo del mondo, due anni dopo, da un reporter che certamente non aveva visto la foto di Vallinotto. Un’altra prova che Geoff Dyer ha ragione, quando scrive che esiste un deposito misterioso di immagini che premono per diventare fotografie e spesso ci riescono, nelle situazioni più diverse e con la collaborazione inconsapevole dei fotografi più diversi. Ma è proprio in quel momento, quando l’immagine archetipa si cola in uno stampo fornito dalla realtà, in questi due casi una dolorosissima realtà, è in quel momento che la storia dell’immagine e quella del suo soggetto cominciano a divaricarsi.
La prima, l’icona, prende la strada maestra della coscienza collettiva. Fa il suo lavoro, entra nelle case, si impone agli occhi, esplode, fa scandalo, oppure (o subito dopo) viene archiviata, dimenticata. Queste due fotografie esplosero. A entrambe viene attribuito il merito di aver girato una pagina della storia. Molte mani in realtà girarono quelle pagine: non sopravvalutiamo le immagini, non invertiamo il rapporto fra condizioni e mezzi.
Il secondo, il soggetto, torna quasi sempre a vivere un’esistenza segreta ai più. Di Kim Phuc sappiamo quasi tutto: quanto quella immagine finì per perseguitarla, e che alla fine lei scelse, se non di rinnegarla, di fuggire al destino che le aveva imposto, quello di bandiera ideologica e propagandistica. Della bambina di Villa Azzurra sappiamo assai meno. Mauro, che ha fatto qualche ricerca, mi dice che probabilmente si chiamava Maria, e che come altri piccoli pazienti di quell’inferno fu trasferita in fretta ad altri istituti dove rimase fino a quando, pare, vi morì, all’età di quattordici anni, per un rigurgito.
Dobbiamo essere grati alle fotografie benintenzionate, ai messaggi che mandano, agli effetti che ottengono, anche quando si caricano di significati più ampi e diversi dall’occasione che le generò. Ma ha ragione Simona Vinci, che ha chiamato “Non ti scordar di me” quel capitolo del suo libro.
Ricordiamoci anche di Maria, se questo è il suo nome, che prestò senza poterlo scegliere, ma con quello sguardo che semra averne consapevolezza, il suo corpo umiliato a una fotografia che probabilmente non vide mai, che cambiò la sorte di molti, molto meno la sua.